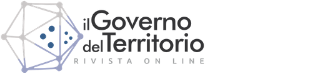Una visione politica della cultura
- Post by: Giulia D'Argenio
- 20 Dicembre 2021
- Comments off
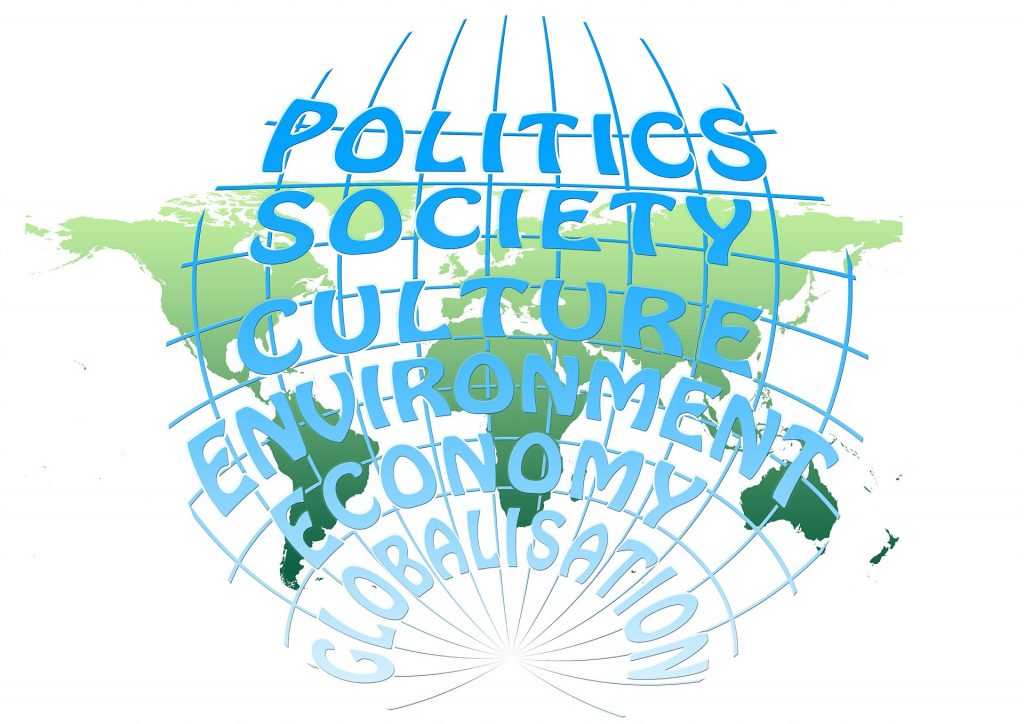
Le immagini di Venezia vuota, città fantasma, desertificata dalla sua dimensione umana, sono diventate il simbolo dell’Italia ferita dalla pandemia. Dell’Italia e del suo patrimonio storico e culturale che definisce l’identità stessa del Paese agli occhi del mondo1. L’emergenza sociale e economica seguita a quella sanitaria ha messo a nudo la fragilità di una divisione globale del lavoro che trova proprio nella vicenda delle città l’emblema2.
Gli spazi urbani con un rilevante patrimonio storico, artistico, architettonico (come Venezia o Firenze) o che hanno puntato sullo sviluppo di attività culturali – qualsiasi cosa ciò voglia dire per riprendere lo storico dell’arte Salvatore Settis3 – sono diventati la struttura produttiva della cosiddetta industria del turismo e dell’intrattenimento.
È così che l’organizzazione dell’economia globale e la rete di mobilità internazionale hanno trasformato tali realtà in circuiti di attrazione, non di rado privati della loro anima originaria, espulsa ai margini dai processi di turistificazione.
I canali vuoti e le attività commerciali in crisi per l’assenza di visitatori hanno cristallizzato la debolezza di politiche economiche e di governo del territorio fondate su un’unica attività: il turismo. Un approccio che ha ridimensionato la visione del patrimonio culturale come bene comune a disposizione, prima di tutto, delle comunità. Di chi i luoghi li abita. E li tiene vivi.
Una visione della cultura che ne fa un “veicolo di coesione economica e sociale”4 che la stessa Unione Europea sostiene. Lo attesta, per esempio, l’esperienza delle Capitali Europee della Cultura, inaugurata nel 19855, e la scelta di proclamare il 2018 Anno del patrimonio culturale per “sensibilizzare alla (sua) importanza sociale e economica”6.
Punto di confluenza tra passato e presente, per l’Ue il patrimonio dei suoi Stati membri (cultural heritage) sostiene il senso di appartenenza dei cittadini alla comune casa europea e costituisce un bene universale da consegnare alle generazioni future. In questo passaggio è insito il nodo delicatissimo del rapporto tra fruizione e conservazione, accessibilità e tutela del valore di un bene artistico, architettonico, paesaggistico. Al quale è direttamente connesso il tema della vivibilità delle città che tale patrimonio contengono. Città che sono un elemento determinante della modellazione del paesaggio.
Le immagini delle moltitudini di turisti assiepate nelle principali località d’arte e costiere, da un capo all’altro d’Italia, contrapposte a quelle che nel lungo e luttuoso 2020 le hanno immortalate completamente vuote, sono istantanee del dibattito contemporaneo sullo sviluppo urbano, sulla definizione dello spazio antropico e sul modello economico collegato alla cosiddetta economia della cultura. Un dibattito che rimarca due necessità in particolare. Da un lato, la definizione di un equilibrio nuovo tra l’uomo e i suoi spazi di vita. Dall’altro, una maggiore attenzione alla cultura come strumento di sviluppo. Sociale prima ancora che economico.